Cinque casi nel sud-est.
Intervento dell’Arch. Salvatore Tringali al Convegno.
Come spesso accade i danni che si producono, a seguito di un evento sismico, negli edifici in muratura sono la concausa di più fattori; quelli più frequentemente riscontrati sono l’effetto di modifiche strutturali, apportate in epoche successive alla prima fondazione dell’edificio, che spesso risultano essere realizzate in contrasto con la corretta regola dell’arte ed in difformità ai regolamenti vigenti: sopraelevazioni, rifacimenti di intere porzioni di fabbrica, con il ricorso a tipologie strutturali difformi da quelle originarie e spesso incompatibili con esse, eliminazione di muri portanti, sostituzione di tetti in legno con solai in cemento armato o in latero-cemento e conseguente realizzazione di cordoli di coronamento in calcestruzzo armato, ecc….
Osservando i danni prodotti da un sisma, spesso ci si interroga sui motivi della diversa risposta sismica di edifici contigui o comunque prossimi tra loro, che reagiscono all’onda sismica in maniera totalmente differente, non subendo gli stessi danni. La risposta va ricercata nella correlazione tra natura dei terreni di fondazione, tipologia strutturale e rispondenza della costruzione alla cosiddetta “regola dell’arte”,
I terremoti non si possono prevedere, questo è un dato certo, ma la vulnerabilità sismica degli edifici si.
E’ questo il tema da sviluppare.
Cominciando a studiare gli effetti che ha prodotto il terremoto dell’Abruzzo sugli edifici in muratura si ha evidenza di quelli che possiamo ipotizzare come “errori costruttivi”, commessi nel tempo dall’uomo, spesso inconsapevolmente, attraverso interventi di rifacimento e/o sostituzione apparentemente“risolutivi”, frutto dell’applicazione di tecniche edificatorie e materiali a volte incompatibili con la tipologia muraria originaria, e alle quali oggi si deve porre riparo con la dovuta fermezza.
A seguito di alcuni sopralluoghi nell’area colpita dal terremoto dell’aprile u. s. e sulla base di un’analisi intuitiva, condotta con la vista diretta abbiamo potuto osservare alcuni edifici storici secondo la seguente classificazione schematica, operata in base ai danni riscontrati:
Edifici nei quali sono stati in precedenza eseguiti interventi di consolidamento poco compatibili con la struttura muraria originaria, nei quali il sisma ha prodotto danni rilevanti ed in parecchi casi anche crolli.
Edifici consolidati, attraverso tecniche idonee e materiali compatibili, i quali hanno resistito all’onda sismica, subendo danni limitati.
Edifici che non hanno subito nel tempo alcun intervento di consolidamento, tra i quali abbiamo distinto quelli le cui buone caratteristiche costruttive, (ben dimensionati, costruiti secondo la corretta regola dell’arte e con materiali idonei e di buona qualità) hanno consentito di rispondere bene all’onda sismica, riducendo i danni a quelli cosiddetti fisiologici, e quelli invece le cui caratteristiche costruttive scadenti (povertà dei materiali di costruzione, errori costruttivi, sottodimensionamenti ecc.) hanno fatto sì che fossero estremamente vulnerabili, per cui il sisma ha prodotto danni di notevole entità ed in alcuni casi anche crolli.
In alcuni edifici in muratura dell’Aquila, i maggiori danni sono stati causati dagli irrigidimenti sommitali e verticali, realizzati a partire dagli anni ’50, con travature e pilastri in cemento armato, in un’ ottica di “miglioramento strutturale” che, come abbiamo potuto constatare, si è rilevato scorretto. Vedasi il caso della Fortezza Spagnola, dove il crollo si è verificato proprio nella parte in cui, era stato eliminato il tetto originario in legno e sostituito con un tetto in latero-cemento, apparecchiato su un cordolo sommitale in cemento armato.
Dalle prime ricognizioni tra gli edifici in muratura danneggiati si è avuta la riprova di quelle che ormai costituiscono, per gli addetti ai lavori, delle certezze, ossia gli effetti negativi che il cordolo sommitale in cemento armato determina, in caso di sisma, sulle murature, producendo un’azione di martellamento e conseguente sfaldamento delle murature sottostanti soprattutto nel caso di murature di scarsa qualità.
Altro tema è quello degli irrigidimenti da apporre alle costruzioni in muratura sia in fase costruttiva che nelle successive fasi di restauro o ristrutturazione.
L’apposizione di tiranti in ferro, il cui uso ha salvato decine di facciate dal ribaltamento, come abbiamo potuto riscontrare in alcuni edifici de L’Aquila, rimane il presidio più efficace e meno invasivo.
Questi presidi hanno prodotto un buon effetto ovviamente laddove sono stati correttamente posizionati e si è in presenza di una muratura ben ammorsata e di buona qualità.
Nello specifico degli edifici indagati, allo stato, si è potuto notare che, nella maggior parte dei casi, i fenomeni di crollo non sono stati originati da problematiche collegate a cedimenti fondali.
Anche i tetti in legno spingenti hanno causato alcuni danni, come nel caso della scuola elementare De Amicis, dove nella parte della torretta è crollato il muro sommitale a causa della spinta delle teste delle travi che lo sostenevano.
Un primo sommario giudizio va necessariamente nella direzione di una maggiore ricerca della qualità del costruire e del ristrutturare, con il ricorso all’applicazione di tecnologie e presidi, anche abbastanza semplici, quali il buon ammorsamento delle murature, l’apposizione di catene in ferro o in legno, come abbiamo visto in molti edifici dell’Aquila, ma compatibili con la tipologia costruttiva del manufatto in esame, dove l’ancoraggio esterno, con bolzone, posto esternamente in corrispondenza delle teste delle travi delle capriate, costituisce una catena in legno del tutto efficace, come nel caso di Palazzo Camponeschi, sede della facoltà di Lettere.
Argomento totalmente diverso è l’analisi del crollo della Chiesa di S. M. Paganica a L’Aquila dove una serie di concause hanno prodotto il rovinoso crollo che per certi versi risulta essere uno dei più disastrosi, tra gli edifici religiosi di tutta la città del L’Aquila, quantomeno per ampiezza dell’area di crollo, avendo interessato praticamente tutta la superficie della chiesa, ad eccezione dei muri perimetrali.
Nel primo nostro sopralluogo a L’Aquila, qualche settimana dopo il 6 aprile u. s. alla visione delle rovine della Chiesa abbiamo immediatamente accostato il crollo di S. M. Paganica a quello della nostra Cattedrale S. Nicolò a Noto avuto il 13 marzo 1996 non per un terremoto ma per il cedimento strutturale di uno dei pilastri della navata destra.
I due edifici, a parte le cause diverse dei crolli, hanno, dal punto di vista della storia strutturale, molte similitudini negative in comune.
1)La realizzazione di tetti e cordoli in cemento armato in sostituzione dei vecchi tetti in legno
2)La mancanza di ammorsature e tirantature
3)La cattiva qualità dell’apparecchio murario.
Dopo aver visionato alcuni edifici danneggiati, accompagnati dall’Arch. Tempesta della Curia de L’Aquila, entrammo dalla porta principale della chiesa di S. M. Paganica e provammo la stessa sensazione di quando entrammo, la mattina del 14 marzo 1996, dall’abside, all’interno della distrutta Cattedrale di Noto.
La vista del cielo dentro la Chiesa.
Ovviamente scattò in noi, in maniera istintiva, la ricerca degli elementi di analogia tra i due monumenti collassati.
Verificammo subito che avevano avuto in comune il tetto in cemento armato, con molta probabilità realizzato nello stesso periodo, tra gli anni ‘50 e ’60, e che questo ha verosimilmente rappresentato, in entrambi i casi, la concausa dell’entità del disastro, non avendo in comune i due edifici la causa principale del disastro, che è il terremoto solo per S. M. Paganica.
La causa del crollo della Cattedrale di Noto, come infatti abbiamo potuto appurare nei successivi approfondimenti di indagine durati due anni, è stata l’esplosione del primo o del quarto pilastro della navata destra, mentre il tetto in cemento armato è stato l’acceleratore del crollo.
Per Santa Maria Paganica possiamo ipotizzare una concausa oltre che nel tetto in cemento armato anche nella qualità dell’apparecchio murario (questo problema è ricorrente nella maggior parte dei monumenti Aquilani ).
Altra causa potrebbe essere, naturalmente tutta da verificare, la diversa rigidità prodotta dalla presenza della torre di difesa del 1300, inglobata all’interno della struttura muraria della navata di destra e divenuta nel tempo torre campanaria.
Un particolare in comune per le due chiese riguarda la data del 1703 che rappresenta per Santa Maria Paganica la data di un terremoto a partire dal quale si fa risalire l’attuale assetto della Chiesa, oggi crollata.
Nello stesso 1703 inizia la costruzione del primo nucleo della Chiesa all’interno dell’attuale Cattedrale di Noto e quindi verosimilmente le costruzioni della Cattedrale di Noto e di Santa Maria Paganica a L’Aquila ebbero inizio contemporaneamente qualche anno dopo, 1703.
Santa Maria Paganica era stata ricostruita e ampliata con delle aggiunte e molto probabilmente all’epoca (1700) si pensò di risolvere il problema già noto della carenza degli apparati murari tramite l’ampliamento delle sezioni dei muri perimetrali e la realizzazione di contrafforti, nella maggior parte dei casi non ammorsati alle preesistenti murature, anche perché l’ampliamento riguardò la realizzazione delle due navate laterali e l’innalzamento della chiesa e del prospetto principale.
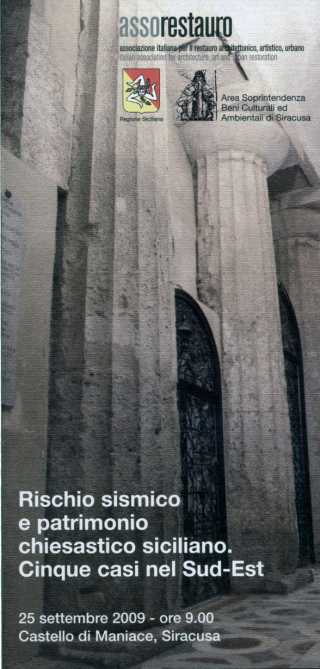
Senza entrare nella trattazione del progetto di ricostruzione della Cattedrale di Noto, condotto assieme all’ing. Roberto De Benedictis con il fondamentale contributo delle maggiori università italiane ed estere tra cui il Politecnico di Milano con la Professoressa Binda e l’università di Berkeley con il Professor Stephen Tobriner, in conclusione, possiamo riflettere su alcuni elementi cardini della ricostruzione della Cattedrale di Noto e del miglioramento strutturale della parte residuata al crollo.
Nuove sottofondazioni delle murature con archi rovesci in muratura armata.
Bonifica delle murature con iniezioni di malta di calce opportunamente studiate per questo edificio.
Interventi di ammorsamento tra murature accostate, come nel caso dei contrafforti esistenti con la navata di sinistra.
Riprogettazione del nuovo pilastro e sostituzione di quelli della navata sinistra.
Realizzazione di cordoli leggeri in muratura armata alla Giuffrè.
Ripristino dell’originario tetto in legno.
Consolidamento degli archi e delle cupole con fibre di materiale composito.

